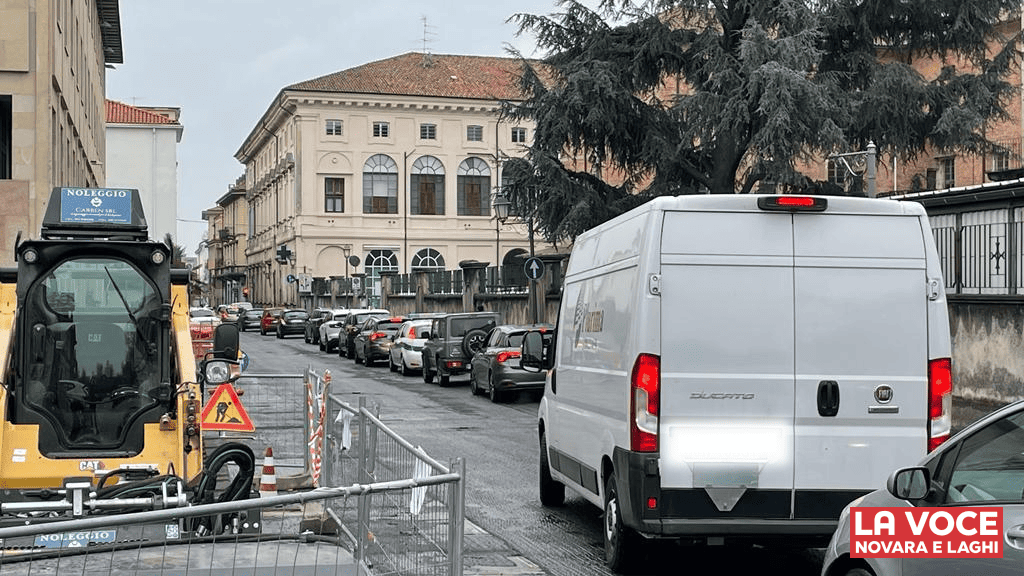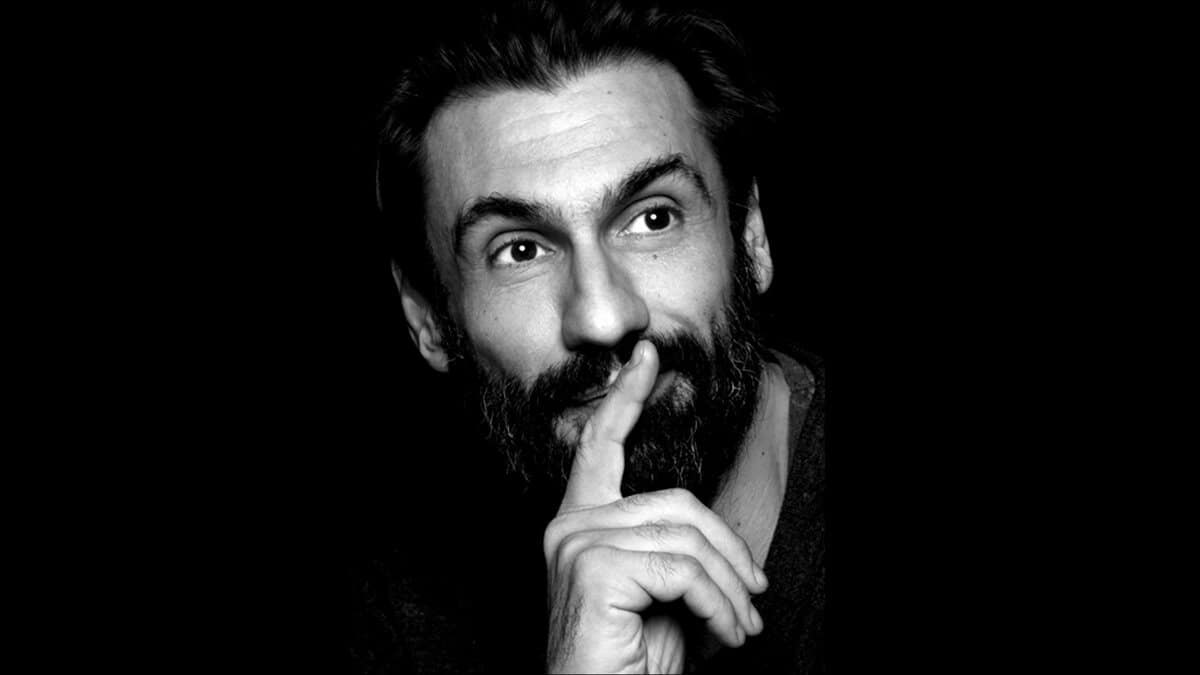Il concerto dell’Earth Ensemble incomincia in maniera avviluppante e, come tutti i progetti che riguardano la terra (e chissà perché?), poteva far preludere ad una serata di elettronica pura e invece così non è stato, perché questo giovane gruppo sembra aver comunque le radici ben piantate nella musica strumentale e anche in quella canora, a dimostrarlo è la “canzone” che apre il concerto che si affranca dal flusso elettronico; la voce particolare di Marta Del Grandi, accompagnata da una chitarra classica e dal pianoforte di Carlotta (nome de plume?) ci porta subito al centro della tematica del concerto: il pianeta.
La fisionomia del concerto è suscettibile di numerose mutazione di tono e di atmosfere ed è un attimo passare dai toni pacati della ballata all’elettronica (con più di uno spunto noise). Le immagini di un pianeta affascinante forte, ma anche fragile, scorrono sullo schermo mentre la batteria di Daniele Patton, scandisce il tempo e il ritmo di tutta la narrazione elettronico-melodica. Con lui anche Michele Marchetti e “Ze in the Clouds” (pseudonym?).
Difficile mettere in scena il “Code de la nature” anche perché, progetti del genere, sono stati più volte intrapresi da molti musicisti, ma l’afflato di questo “Earth Ensemble” sembra sincero e la sincerità in musica (e non solo in musica), si percepisce subito. Le atmosfere si fanno dolci e struggenti quando sullo schermo, sempre in buona sintonia con la musica, passano le immagini di piccole e operose formiche e di sassi ingabbiati in grate e tombini dai quali sembra dover spuntare fuori da un momento all’altro il cuore di Robert Gober della Fondazione Prada. Un piccolo insetto che segue un suo misterioso percorso sulla terra riarsa e desolata sembra condurre l’Ensemble verso il senso ultimo delle cose. Nell’alternarsi dell’elettronica con il pianoforte, la chitarrra tanti gli effetti rumoristici, un flusso intenso e continuo che invade lo spazio Nòva che ospita il concerto.
Non è un gioco facile quello degli equilibri musicali ed elettronici, ma è il risultato della residenza artistica, in questi casi, a dare l’effetto ricercato: affiatamento e un giusto equilibrio tra le parti che comprendono anche le immagini, originali e non scontate di Gabriele Bertotti. Piacevole l’inserto di fisarmonica che introduce una ballata, quasi folk, nel continuum della performance. Ma non c’è certo da stare troppo tranquilli perché le atmosfere, come detto, cambiano repentinamente, come quelle atmosferiche del nostro pianeta inquieto.
Mi sovviene una domanda che mai ha trovato risposta nella storia della musica moderna (e non solo rock): ma è proprio sempre necessario l’uso della lingua inglese nei testi? Un buon concerto per dei giovani musicisti che necessitano di qualche piccola messa a punto, per superare qualche sonorità ancora un po’ acerba.
“Back to the source” come dice il verso finale.