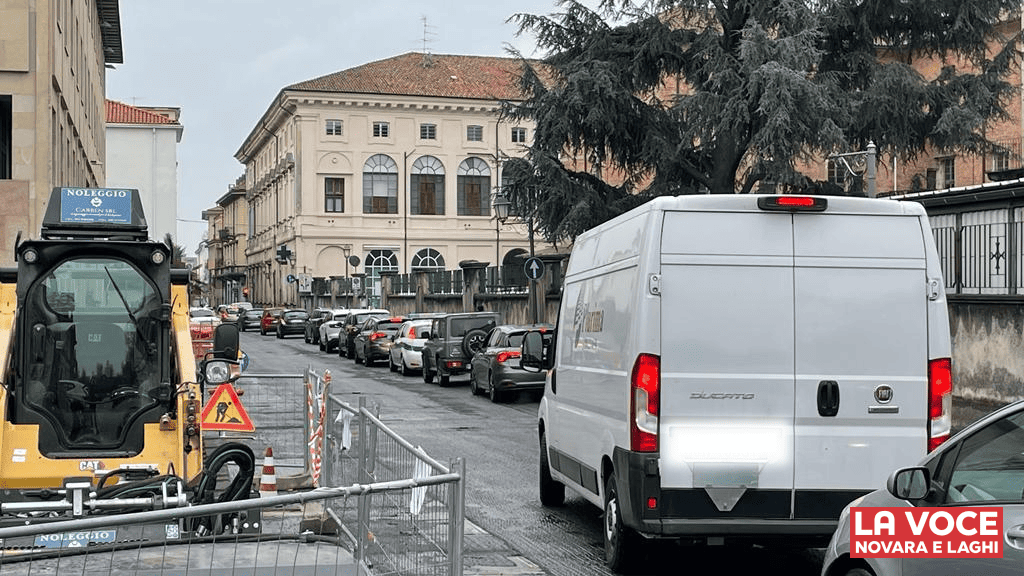La storia della mia vita mi ha portata spesso tanti anni fa tra le stradine di Pasturo, un piccolo paese della Valsassina in provincia di Lecco, sui sentieri e sulla cima della Grigna, montagna arida e aspra, ma da cui nelle notti serene si gode di un silenzioso cielo stellato e si spinge la vista fino alla pianura lontana.
E’ lì che ho sentito parlare per la prima volta della poetessa Antonia Pozzi, dotata di una capacità di sguardo acutissimo nel descrivere e fotografare quelle sue amate montagne, e soprattutto di scrutare tra le pieghe di un cuore travagliato.
Era nata a Milano nel 1912, e aveva tutto per essere felice: una facoltosa famiglia alto – borghese (padre avvocato e madre aristocratica, discendente dello scrittore Tommaso Grossi), studi prestigiosi, frequentazioni esclusive, un palco alla Scala, stimoli dal mondo intellettuale e viaggi. Era una bellezza raffinata in stile anni Trenta, ipersensibile ma non fragile, anzi forte, vitale e curiosa.
L’amore per il suo professore di greco e latino Antonio Maria Cervi, nato nel segno del pudore, dell’affinità e dei comuni interessi, ha certamente segnato il suo destino; la relazione fu osteggiata dal padre, per moralismi di rispettabilità borghese, e da allora Antonia è andata in cerca di un affetto fermo e fedele come argine alla solitudine, alle delusioni, ai fallimenti di altri legami, affidando alla poesia la catarsi del dolore: ‘Come in una fiaba / triste – un altro giardino / si chiude – al margine della strada’.
Non per questo i suoi versi sono limitati ad un orizzonte autobiografico, bensì nutriti di una tensione costante a conoscere il senso delle cose e il dolore universale, a includere, lei così privilegiata, bambini e madri povere, ingiustizie, periferie e fabbriche.

Ma è alla natura e alla sua bellezza che guarda come spazio sacro ed eletto per la creazione poetica: la capacità del suo sguardo di trasformare il paesaggio in un luogo del cuore si rivela nella bravura di fotografa e nella scelta accurata di versi scarni ed essenziali, fatti di parole precise senza orpelli e aggettivi inutili: le mot juste, come diceva Flaubert, a cui non a caso la poetessa ha dedicato la tesi di laurea.
Le immagini nascono spesso dai luoghi famigliari: ‘Ricordo che, quand’ero nella casa / della mia mamma, in mezzo alla pianura, / avevo una finestra che guardava / sui prati; in fondo, l’argine boscoso / nascondeva il Ticino e, ancor più in fondo, c’era una striscia scura di colline… Verso sera fissavo l’orizzonte; socchiudevo un po’ gli occhi…. E la striscia dei colli si spianava, / tremula, azzurra: a me pareva il mare /e mi piaceva più del mare vero’.
Lo sguardo di Antonia arriva a creare ciò che sfugge agli occhi, con un sentimento di nostalgia che è proprio dell’amore di lontananza.
La bellezza dell’universo intero, raccolta nei suoi occhi, diventa un dono da fare all’amato: ‘Ti do me stessa, / le mie notti insonni, / i lunghi sorsi / di cielo e stelle – bevuti / sulle montagne, / la brezza dei mari percorsi / verso albe remote’.
Gli occhi dell’amato però, ‘così densi di cielo, profondi come secoli di luce’ sono lontani, ‘inabissati al di là / delle vette’: la Terra non è luogo dove possa realizzarsi il desiderio di felicità sfuggente all’uomo; la realtà della vita tradisce, Antonia lo avverte da sempre: ‘Quel che a volte ti senti urlare in cuore/…è un abbaglio / l’abbaglio estremo / dei tuoi occhi malati -/ e ciò che fingevi la meta / è un sogno, / il sogno infame / della tua debolezza’.
C’è stato un momento evidentemente, in cui la bellezza del mondo ha smesso di parlarle, e sono rimasti soltanto il dolore, le aspettative deluse, ‘una invincibile disperazione mortale’, i segni indelebili di rimpianto: ‘Chi mi vende oggi i fiori? / Io ne ho tanti nel cuore, ma calpestati’; si è sentita respinta, ‘Sempre così smisuratamente sperduta ai margini della vita reale. Forse davvero il mio destino sarà di scrivere dei bei libri per i bambini che non avrò avuti’.
Dopo il suicidio, il 3 Dicembre 1938, verrà sepolta a Pasturo ai piedi della Grigna, nei luoghi che lei stessa definisce un nido: ‘Qui sono le mie radici, perché ad ogni ritorno tra questi muri, fra queste cose fedeli e uguali, di volta in volta ho deposto e chiarificato a me stessa i miei pensieri, i miei sentimenti più veri’.
Dalla sua finestra vedeva ‘un pezzo di prato libero che mi piace. Vorrei che mi portassero giù un bel pietrone della Grigna e vi piantassero ogni anno rododendri, stelle alpine e muschi di montagna; pensare d’esser sepolta qui non è nemmeno morire: è un tornare alle radici’.
‘Una sera / la tua montagna si ricorderà / di averti avuta / bambina / sul suo grembo d’erba… Il tuo sentiero ti ricondurrà / lungo la valle, / per la conca prativa – al muro candido, / al cancello socchiuso. / Lassù, nel breve orto disteso / ai ritorni delle stagioni, ai cieli / della neve e dei venti / primaverili, / verranno bocche / di bambini sconosciuti / a cantare / sulla tua solitudine’.