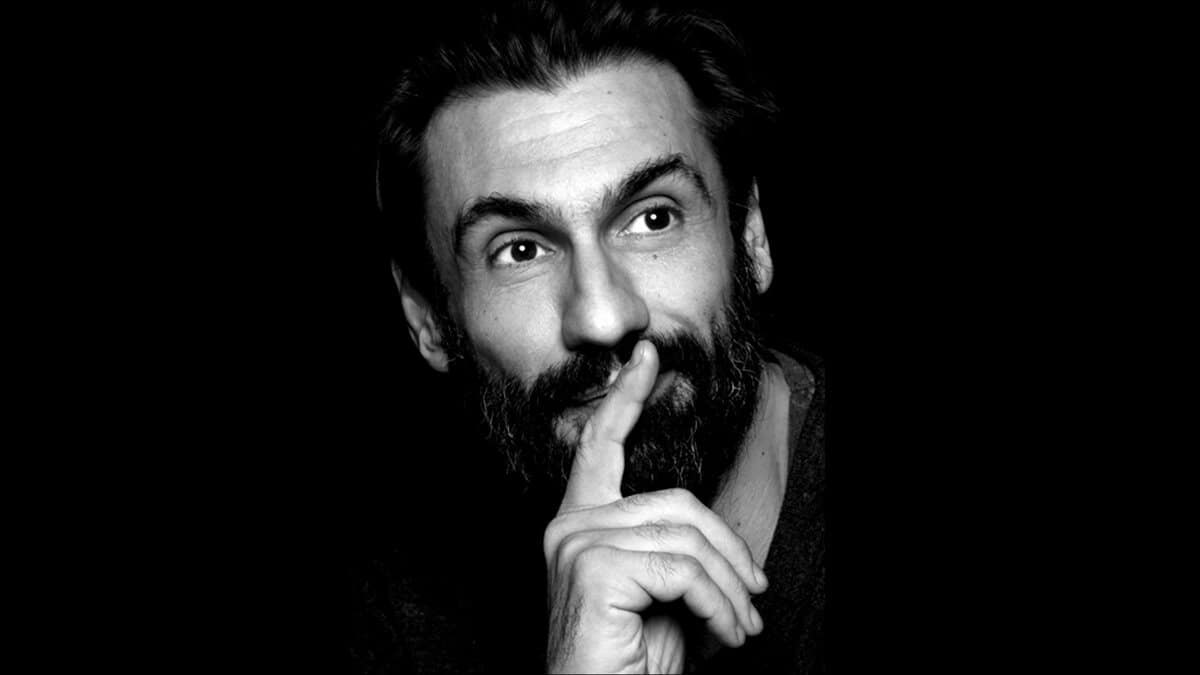In una recente intervista Adriano Celentano ha ricordato la sua celebre canzone, della metà degli anni ‘60, dedicata alla strada milanese in cui abitava da bambino, la via Gluck, un tempo circondata dai prati, poi ben presto sommersa dal grigio cemento degli edifici, un lascito dell’urbanizzazione del dopoguerra.
Il ‘molleggiato’ si chiedeva perché non si lasciasse crescere l’erba e si continuassero invece a costruire “case su case” tra strade di catrame, per poi tornare nel 1972 a cantare che “le fabbriche ci colorano il cielo di nero che odora di morte” e che “il cemento ti chiude anche il naso”.
La palazzina che ispirò la canzone è oggi in stato di degrado, il cortile è un deposito a cielo aperto semiabbandonato, in condizioni da periferia estrema nonostante sia vicino alla stazione centrale, perché capita spesso che in alternativa al recupero di edifici già esistenti ma in disuso si preferisca creare nuovi agglomerati da edificare.
Oggi si parla di lottizzazione e consumo di suolo, e anche noi a Novara abbiamo da combattere le nostre battaglie per districarci tra normativa edilizia e capannoni.
Ma esattamente un secolo prima delle proteste di Celentano, nella Milano del 1866 Arrigo Boito levava la sua voce contro i lavori pubblici promossi dal nuovo Stato, demolizioni e ricostruzioni che portarono nei settenari e negli endecasillabi parole inconsuete e decisamente poco poetiche: “Zappe, scuri, scarpelli. / Arïeti, martelli, / istrumenti di strage e di ruina. / L’impero è vostro! O tempi irrequïeti! / Sorge ogni giorno qualche casa bianca / grave di fregi vieti. / Scuri, zappe, arïeti. / Smantellate, abbattete e gaia e franca / suoni l’ode alla calce e al rettifilo! / Piangan pure i poeti”.
La polemica è soprattutto diretta alla ristrutturazione monumentale dei centri urbani, che hanno messo in moto capitali ingenti e hanno creato occasioni di affari lucrosi e non sempre onesti: “la progenie della lupa e della scrofa”, imprenditori avidi ed immorali regalano “alla vecchia cittade un profilo scomposto e tetro”.
Ritornando agli anni del boom economico, in un’epoca di abusivismo e di crescita rapida e spropositata delle periferie che ha fortemente cambiato i connotati di grandi metropoli e cittadine italiane, ancora una volta Italo Calvino, con le vicende di Quinto Anfossi nella Liguria degli anni ‘50, mette il protagonista di fronte all’ineluttabile destino degli affaristi, in una girandola di permessi e condoni che ha rovinato il paesaggio ligure, e ha aperto la strada allo scempio naturalistico derivato dal tristemente noto fenomeno della ‘rapallizzazione’.
Nel romanzo ‘La speculazione edilizia’, Calvino si rammarica di non aver messo in scena uno dei suoi personaggi paradossali che riescono in quel che vogliono fare, bensì una storia di fallimento e smarrimento, “per rendere il senso di un’epoca di bassa marea morale”: messo da parte il suo impegno di intellettuale e divenuto socio di un impresario di cattiva fama, Quinto collabora ad ingrigire lo spettacolo paesaggistico della riviera ligure: “Ora più nulla, non vedeva che un sovrapporsi geometrico di parallelepipedi e poliedri, spigoli e lati di case, di qua e di là, tetti, finestre, muri ciechi per servitù contigue con solo i finestrini dei gabinetti uno sopra l’altro”.
Storia vecchia? No, ancora oggi dal mare e dal cielo l’acqua si riprende il terreno che il cemento ha sottratto.
Un altro grande artista ligure, un Eugenio Montale nell’inedita veste di eco – attivista affacciato questa volta sul mare campano, si preoccupa del guasto ambientale e naturalistico in un componimento datato 8 marzo 1975, ma solo di recente scoperto al Fondo Manoscritti di Pavia.
Per un poeta nei cui testi il paesaggio è sostanza biografica e metafora della condizione umana, è comprensibile una presa di posizione amara e contestatrice di fronte ad un ecomostro abusivo noto con il nome di Hotel Fuenti di Vietri sul Mare, una massa di 34 mila metri cubi di cemento, che mise a rischio la tenuta della costiera amalfitana e che venne demolito solo nel 1999.
“Pare che prima o poi / anzi prima che poi / sugli Aliscampi che splendono / tra Amalfi e Vietri si vedranno enormi / grattacieli e già sorge dalla cintola insù / l’intellighenzia, con suoi alti piati. / Ma saranno sprecati; grattare il cielo / è ciò che resta a chi non creda più / che un cielo esista”.
Per chiudere il cerchio e tornare a Milano, nel 1955 in ‘Quaderni suburbani’ Carlo Emilio Gadda scriveva: “La città si dilata: la città si estende. Gli urbanisti e i sociologi, gli amministratori del comune, gli impresari edili, i cultori di statistica, i tecnici dell’acqua potabile, del gas, della luce, dei telefoni parlano di sviluppo della città, redigono grafici in ascesa, completano l’incremento di domani; scrivono incremento, sviluppo. Un certo senso compiaciuto, una speranza colorata di certezza, una disposizione emulatrice: arriveremo anche noi ai tre milioni di Parigi, ai quattro di Berlino, agli otto di Londra, e via via”.
Il poeta Luciano Erba invece, nel 1989 osserva che, dopo aver consumato il suolo, l’ hybris dell’uomo punta alla colonizzazione del cielo, con grattacieli oggi convertiti in boschi verticali: “ Abito a trenta metri dal suolo / in un casone di periferia / con un terrazzo e doppi ascensori. / Questo era cielo, mi dico / attraversato secoli fa / forse da una fila di aironi / […]e bei cavalli in riva agli acquitrini. / Questo mio alloggio e altri alloggi / libri stoviglie inquilini / questo era azzurro, era spazio / luogo di nuvole e uccelli. / L’aria è la stessa: è la stessa? / Sopravvivere: vivere sopra?”.
Lo sguardo sulla città dall’alto insinua nel poeta il dubbio se quella respirata al trentesimo piano di un palazzo della periferia milanese sia la stessa aria del passato.