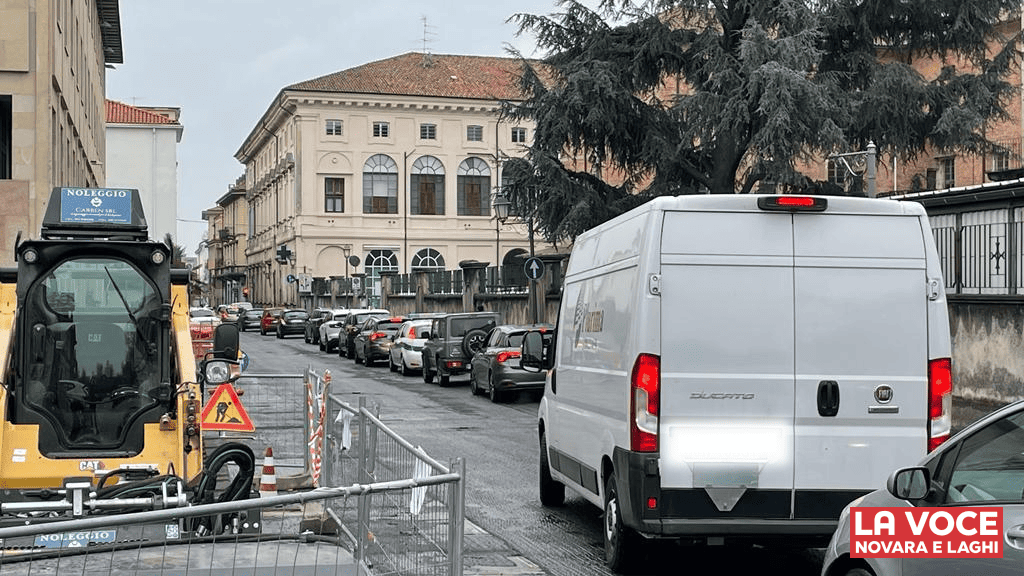A dispetto della burrasca di fine estate che porta con sé calo termico, allerta sui livelli di guardia dei fiumi e fenomeni estremi, nella rovente stagione appena conclusa, che nell’area mediterranea ha visto il dominio incontrastato dell’anticiclone africano, grandi aree del Pianeta hanno continuato a fare i conti con la siccità, anche l’Italia, alle prese con la crisi delle produzioni agricole, la scomparsa della neve sulle Alpi e la compromissione di interi ecosistemi.
In letteratura sono tante le pagine segnate da stagioni aride e punizioni divine, alcune profetiche, altre distopiche, molte interessate al fenomeno naturale come metafora di aridità esistenziale.
Nella Bibbia la siccità, alla pari del diluvio, è spesso il prezzo da pagare per l’arroganza umana, come ricorda il profeta Geremia: “Giuda è in lutto, le sue città languiscono, sono a terra nello squallore; il gemito di Gerusalemme sale al cielo. I ricchi mandano i loro servi in cerca d’acqua; essi si recano ai pozzi, ma non ve la trovano e tornano con i recipienti vuoti. Per il terreno screpolato, perché non cade pioggia nel paese, gli agricoltori sono delusi e confusi. Se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, Signore, agisci per il tuo nome! Certo, sono molte le nostre infedeltà, abbiamo peccato contro di te”.
Il terribile ricordo di stagioni aride compare nei romanzi del Verismo, come ‘Il marchese di Roccaverdina’ di Luigi Capuana, dove “la lunga siccità aveva reso duri come il ferro i terreni, e i vomeri ordinari non riuscivano a spezzarli per preparare i maggesi”. ‘I Malavoglia’ di Giovanni Verga adottano un punto di vista popolare che mette il cambiamento in relazione con il progresso, e “Padron Cipolla lo sapeva lui perché non pioveva più come prima. Perché hanno messo quel maledetto filo del telegrafo, che si tira tutta la pioggia, e se la porta via”. In un dialogo che piacerebbe ai complottisti, Compare Zuppiddo proponeva di “tagliarli tutti quei pali del telegrafo, e buttarli nel fuoco!”, perché “dentro il filo ci era un certo succo, che si tirava la pioggia dalle nuvole, e se la portava lontano”.
I primi migranti climatici della letteratura sono quelli raccontati da John Steinbeck in ‘Furore’ nel 1939: è la storia della famiglia Joad che si trasferisce attraversando gli USA dall’Oklahoma alla California, perché espropriata dalle banche delle proprie fattorie: il terreno non dà frutti, il ‘dust bowl’ (la tempesta di polvere) ha reso le coltivazioni poco redditizie.
“Verso la metà di giugno le nuvole del cielo, alte, pesanti, gravide di pioggia, si mobilitarono nel Golfo ed iniziarono la loro marcia di invasione nel Texas. Gli uomini nei campi levavano gli occhi verso di esse e annusavano l’aria e rizzavano dita bagnate di saliva per ragguagliarsi sulla provenienza del vento. Passate le nuvole arrivò un venticello che, sospingendole verso settentrione, faceva mormorare sommesso il granturco annaffiato. Passò un giorno e il vento aumentò di intensità e di costanza. La polvere s’alzò dalle strade e coprì le ortiche dei fossi e si spinse anche addentro nei campi di granturco. Il vento si fece impetuoso e si accanì nel rodere la crosta lasciata dall’acqua nei campi. A poco a poco il cielo si oscurò, perché il vento continuando a raschiare la crosta metteva in libertà la polvere e se la portava via, insieme con frotte di foglie morte e fili di paglia. Il sole splendeva rosso nell’aria oscura e fredda. Una notte il vento impazzò, zappò furiosamente la terra attorno alle radici del granturco, e il granturco si mise a lottare per difesa contro il vento agitando le sue foglie indebolite, ma nella lotta le radici risultarono denudate dalle zolle di terra protettrice e ogni pianta risultò inclinata nella direzione del vento”.
I semi del furore, lasciati cadere lungo il viaggio accidentato verso una terra che rimarrà solo promessa, germoglieranno in rabbia e delusione: fuggiti dalla siccità, i Joad e i loro compagni in California troveranno un’inondazione. Il clima si accanisce. E insieme al clima che si fa beffe di un popolo cacciato e stremato, le offerte di lavoro sono altrettanto beffarde: salari indegni per lavori faticosissimi.
Anche un film può aiutare a riflettere su come una catastrofe ambientale si accompagni a quella sociale, è il caso di ‘Siccità’ di Paolo Virzì, ambientato in una Roma apocalittica dove non piove da tre anni e il bacino del Tevere è prosciugato: non più una commedia italiana in cui il conflitto tra classi sociali ha alle spalle il boom economico, ma una crisi ecologica da cui si impara che l’acqua non è scontata, ma una risorsa preziosa e scarsa, e che l’aridità può anche essere quella di chi vive della sua fama sui social, ma è in crisi con se stesso, e di chi si vende al sistema.
Per tornare alla letteratura, una pagina magnifica e memorabile rimane quella tratta dal romanzo di Tomasi di Lampedusa ‘Il gattopardo’, in cui il Principe di Salina riflette su come il clima e il paesaggio abbiano inciso negativamente sull’animo degli abitanti, radicandoli in una immobilità senza prospettive future.
“La Sicilia, l’ambiente, il clima, il paesaggio. Queste sono le forze che insieme e forse più che le dominazioni estranee e gl’incongrui stupri hanno formato l’animo: questo paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza lasciva e l’asprezza dannata; che non è mai meschino, terra terra, distensivo, umano, come dovrebbe essere un paese fatto per la dimora di esseri razionali; questo paese che a poche miglia di distanza ha l’inferno attorno a Randazzo e la bellezza della baia di Taormina, ambedue fuor di misura, quindi pericolosi; questo clima che c’infligge sei mesi di febbre a quaranta gradi: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre; sei volte trenta giorni di sole a strapiombo sulle teste; questa nostra estate lunga e tetra quanto l’inverno russo e contro la quale si lotta con minor successo; da noi si può dire che nevica fuoco, come sulle città maledette della Bibbia; in ognuno di quei mesi se un Siciliano lavorasse sul serio spenderebbe l’energia che dovrebbe essere sufficiente per tre; e poi l’acqua che non c’è o che bisogna trasportare da tanto lontano che ogni sua goccia è pagata da una goccia di sudore; e dopo ancora, le piogge, sempre tempestose che fanno impazzire i torrenti asciutti, che annegano bestie e uomini proprio lì dove una settimana prima le une e gli altri crepavano di sete. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti, anche del passato, magnifici ma incomprensibili perché non edificati da noi e che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti; tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati e sempre incompresi, che si sono espressi soltanto con opere d’arte per noi enigmatiche e con concretissimi esattori d’imposte spese poi altrove; tutte queste cose hanno formato il carattere nostro che rimane così condizionato da fatalità esteriori oltre che da una terrificante insularità di animo”.